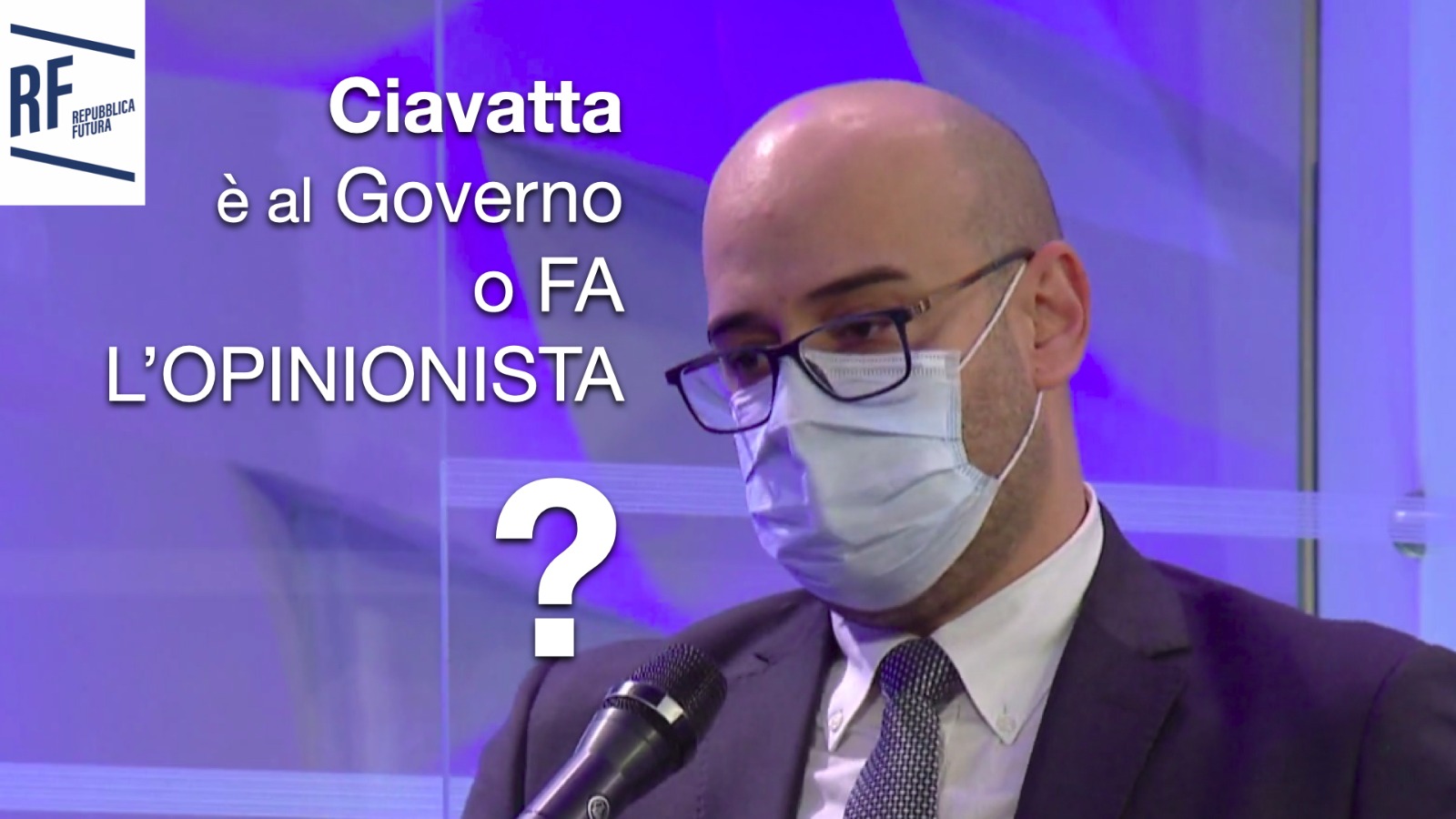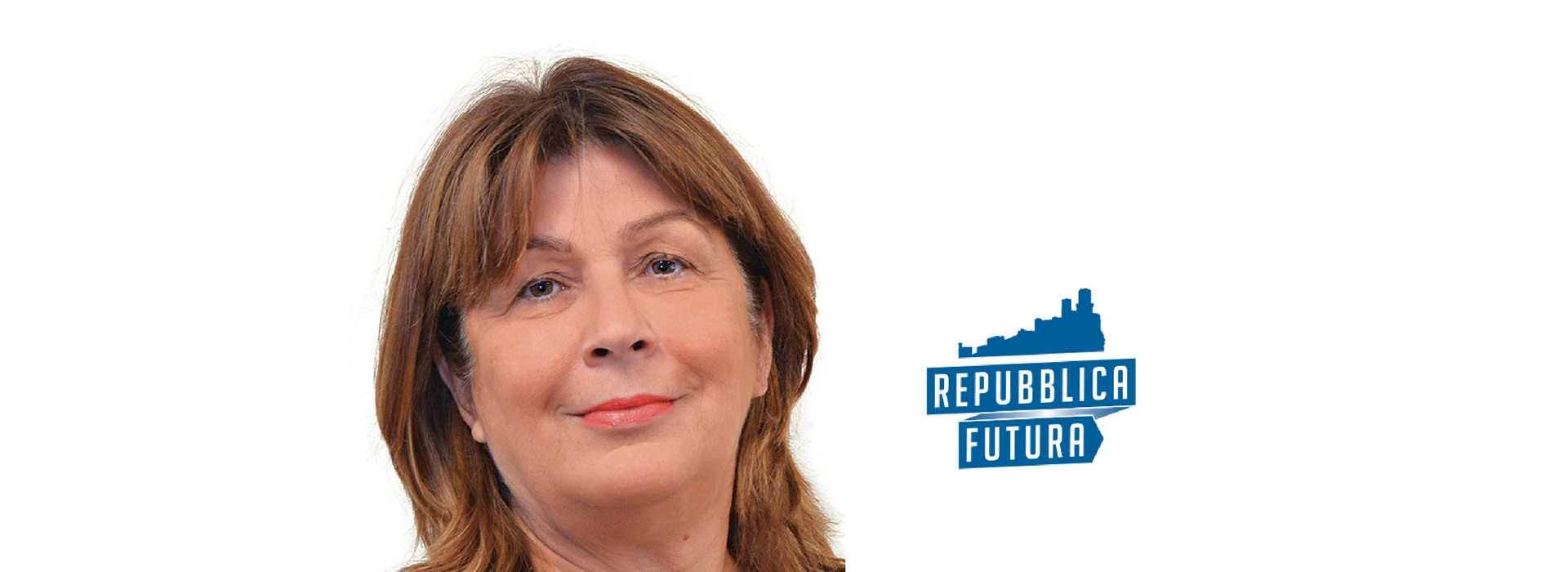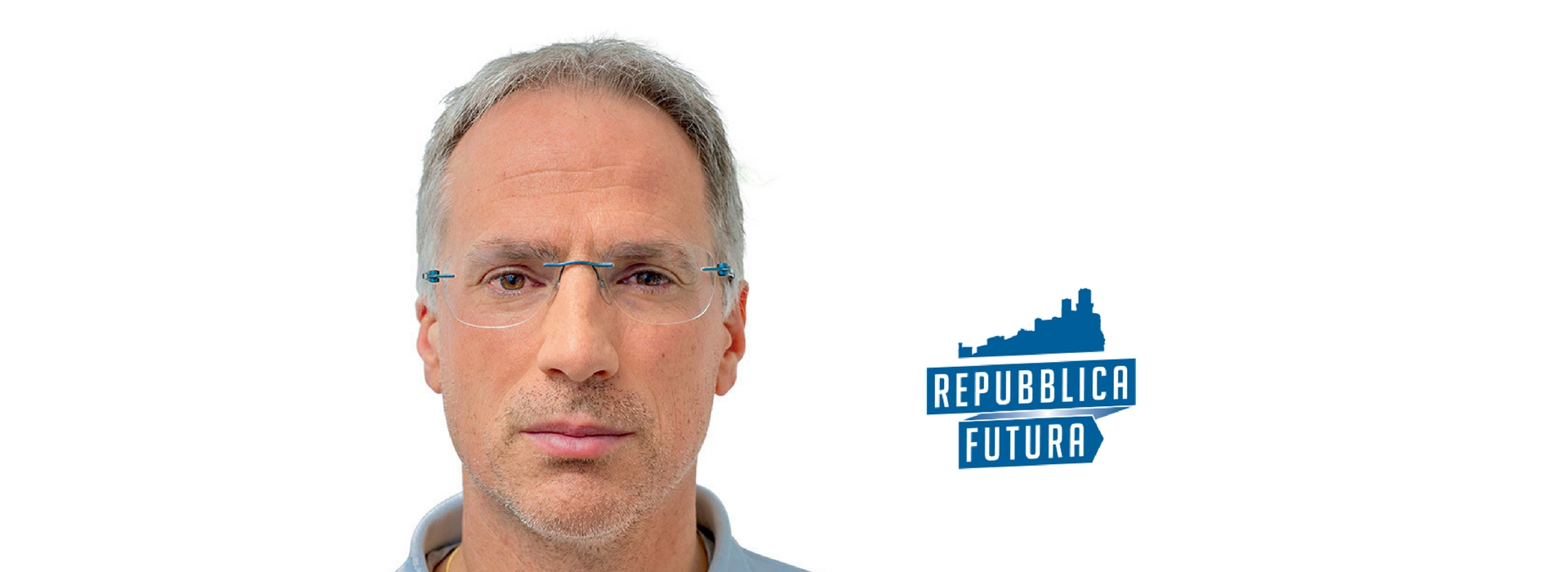“Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio”
Inizio da qui.
Citando un passo del testo di Ippocrate, il caposaldo simbolico dell’inizio della professione medica sul quale ancora oggi si appone il giuramento. Risale circa al 420 a.C.: la data non è una mera citazione da libro di storia della medicina, ma lo stimolo per una riflessione che proverò a condividere in seguito.
L’argomento eutanasia ha percorso i secoli, alimentando il fuoco del dibattito: filosofico, morale, medico, e in seguito anche religioso ed etico. Mantenendo vivo il fascino della morte. Sì, il fascino.
Apparentemente un ossimoro stridente. In realtà il contraltare, ciò che Freud definiva istinto di morte, all’istinto di sopravvivenza. Nel tentativo umano di mantenere sé stessi in un equilibrio dinamico tra il senso di vita e di piacere, e la riscoperta del senso di morte come autodistruzione continua come unica strada per rinnovarsi.
Sorvolando gli aspetti filosofici, che mi porterebbero troppo lontano, tuttavia la morte accompagna ineluttabilmente i pensieri di ogni popolazione e di ogni individuo.
Perché il punto, e torniamo a noi, è proprio questo: la morte è una fase della vita, appartiene alla definizione stessa di essere vivente la fase della cessazione della vita.
Come si potrebbe pensare, e credo di cogliere l’essenza dell’istanza d’arengo, di NON tutelare la qualità e la dignità della morte?
Anche e soprattutto quella che occorra dopo lunghi periodi di malattia? Direi che sia inevitabile, prima che doveroso.
Qualche anno fa, un’esperienza in missione in un ospedale del Madagascar, quello più povero, mi ha insegnato il senso della morte, e come una popolazione, certamente agli antipodi dalla nostra, viva tale esperienza: un’esperienza di comunità, una festa per chi, liberato dalla malattia e dalla sofferenza ritorni alla Terra. Una composta consapevole accettazione.
Ritornando alla nostra longitudine, più occidentale, è andata consolidandosi negli ultimi decenni, come ho già avuto modo di dire altrove, la tendenza ad una “cronicizzazione” delle malattie, talora ad ogni costo. Talora oltre le armi mediche disponibili per il contrasto alla malattia stessa. In un timore e in una riverenza della morte, talora eccessivi, talora immotivati.
Sia chiaro da subito: l’obiettivo è la difesa strenua della vita. Sempre e comunque. E non certo, cito dall’istanza, rendere la morte “un’alternativa poco costosa alle cure palliative“. Ciò non può e non deve essere in discussione. Come dire? Non è questo il punto.
L’eutanasia è, sarebbe, solo il gesto messo in essere per l’interruzione della vita, l’atto estremo ed ultimo. Occorre piuttosto puntellare e contenere il paziente, l’essere umano, durante il suo percorso di malattia terminale.
Cura palliativa deriva dal latino pallium, mantello: l’atto empatico e generoso di fornire una figurata copertura che dia calore. Il calore di una adeguata terapia farmacologica che allevi i sintomi, il calore di una adeguata terapia assistenziale.
Inscindibile, mai come in questo capitolo della medicina, il ruolo del medico da quello dell’infermiere.
Perché? Perché il percorso del paziente terminale, con prognosi infausta, corre su un binario. Una rotaia è la lotta al dolore, al dolore fisico, che purtroppo spesso si accompagna a queste fasi, dolore che necessita di adeguata terapia farmacologica specialistica. Ma nessun farmaco, da solo, toglie – ed è la seconda rotaia – la sofferenza.
Cioè l’elaborazione, a livello cosciente, di ciò che sta accadendo, i pensieri, i fantasmi, le angosce le paure ataviche e ancestrali. Che accompagnano l’essere vivente nel momento dell’exitus. Ben più difficile da contrastare.
Impossibile farmacologicamente (a meno di abolire le funzioni cognitive superiori con la sedazione).
Possibile con l’istituzione di un team polispecialistico che si faccia carico di quel paziente.
Appunto, come scritto nel testo: Empatia, soffrire in, dentro.
Ancora di più che simpatia, soffrire con.
Non dunque, e cito l’istanza, “una costrizione ad agonie prolungate”.
Il contrario.
Obiettivo: condividere il carico emotivo e di sofferenza.
Tutto questo tradotto in una parola? Hospice. La capacità di farsi carico della tutela di questa difficilissima fase di vita istituzionalmente. Il luogo più ovvio? L’ospedale.
Il nostro ospedale manca, oggi di un hospice. Che affianchi, certo non soverchi, il sistema di gestione territoriale domiciliare, già esistente e funzionante. Un sistema costruito per accompagnare il percorso del paziente nel difficile passaggio della malattia terminale. Come dire, prendiamo per mano il paziente ben prima del momento della morte.
Non significa certo non voler parlare di eutanasia. Tutt’altro. Tanto è vero che proporremo un odg al termine del mio intervento, anche facendo seguito a ciò che è scritto negli ultimi capoversi di questa istanza.
Senza timore posso affermare che molti degli specialisti in forza al nostro ospedale, medici anestesisti-rianimatori-antalgologi, oncologi, internisti, nonché degli infermieri di questi stessi reparto sono pronti, sono disponibili alla realizzazione di un hospice. La stessa Associazione Oncologica Sammarinese si è mostrata favorevolmente interessata.
Per tutto questo l’intenzione della maggioranza è respingere l’istanza ma con l’impegno in un odg.
Anche perché non può essere accettato il passaggio, e cito “diversi medici aiutano i loro pazienti a morire somministrando antidolorifici a dosi letali“.
No.
No e rimando al giuramento di Ippocrate con cui ho esordito.
No poiché non si tratta di dosi letali ma l’impiego di mezzi per alleviare dolore e sofferenza (per esempio: l’uso di morfina) che può causare, come effetto secondario, la diminuzione dei tempi di vita.
Non certo l’interruzione volontaria e consapevole della stessa.
Assicuro i concittadini firmatari, da professionista che lavora nella trincea di una rianimazione, che nessun medico somministra dosi letali. O che metta in atto alcuna forma di eutanasia.
Infine, l’ultima riflessione che avevo anticipato all’inizio.
Seppure il problema del fine vita sia stato sollevato nel 400 aC, ben prima cioè dell’era storica del cristianesimo, inevitabilmente, e aggiungerei doverosamente, il problema è stato permeato dalla religione. Dalle religioni. La fede, la Fede con l’iniziale maiuscola nel momento di un evento poco spiegabile e difficilmente accettabile. La fede inviolabile nel momento della difficoltà umana.
Sacralità della vita. Espiazione. Vissute con dignità.
Mai come in questo ambito la visione politica deve essere ampia e incolore. Per la tutela, nel rispetto, di questa fase di vita di ogni singolo essere umano.
Una trentina di anni fa, dunque più o meno adolescente, ho sentito la definizione ad oggi migliore di eutanasia che abbia mai letto anche sui tomi sacri della scienza medica.
Eutanasia: Allontanamento dolce dalla società.
La ricordo ancora nitidamente. Perché ad usarla fu un sacerdote, durante un’omelia, in una piccolissima sperduta e aguzza chiesetta in montagna durante una settimana bianca.
Credo che sul tema occorrano strumenti tecnici, morali e d’esperienza. Difficili da trovare in un unico interlocutore, possibili con il supporto di tutti. Poiché sulla vita storicamente si sono articolate due visioni contrastanti: libertà e sacralità.
Io mi sono convinto che si possano conciliare:
Libertá assoluta sulla propria,
Rispetto sacrale assoluto per quella degli altri.
La miglior sintesi che finora io abbia trovato.